Un recente libro di Paul Bloom intitolato in questo modo – ma senza il punto interrogativo! – mi ha di primo impatto infastidita: sarà il solito titolo provocatorio per attirare i lettori.
Ormai sono diversi anni che conduco ricerche su questo tema e sono sempre stata fermamente convinta che promuovere le competenze empatiche, soprattutto a partire dalla tenera età, sia uno degli strumenti più utili per costruire e mantenere nel tempo relazioni positive e soddisfacenti e per coltivare rispetto degli altri e valorizzazione delle diversità. Bene, quindi non lo leggerò quel libro…
Quando cerchi di evitare qualcosa però, ti balza sotto gli occhi quando meno te lo aspetti, e di continuo. Ma no, non voglio comprare il libro. Alla fine però, decido di curiosare su internet: chi è questo Bloom? Non ci vuole molto a scoprire che si tratta di uno psicologo, professore all’università di Yale, che studia da tempo il “fenomeno” dell’empatia, cerando di osservarlo in maniera critica, ovvero interrogandosi, senza darne per assodata l’assoluta bontà, sull’effettiva utilità dell’essere empatici “ad ogni costo”.
Cerco allora degli articoli scientifici di Bloom e ne trovo uno in particolare del 2017, che comincia davvero ad interessarmi: come molti altri studiosi, anche lui ci tiene a sottolineare che il termine empatia sottende diverse competenze, quindi parlare di un generico “senso empatico” sarebbe fuorviante. D’altro canto, lo stesso Hoffmann – uno dei più noti teorici dell’empatia – ne ha parlato come un costrutto multicomponenziale, distinguendone una dimensione affettiva, una cognitiva ed una più motivazionale. Bloom asserisce che ci sono almeno quattro “common senses” di empatia: 1. Comprendere i pensieri ed i sentimenti degli altri; 2. Sperimentare in prima persona le emozioni di chi ci sta vicino (una sorta di “contagio emotivo”); 3. Sperimentare le emozioni provate da altri, non necessariamente vicini a noi, immaginare di mettersi nei loro panni emotivamente (“empatia affettiva”); 4. Provare sentimenti positivi verso gli altri, desiderare che non soffrano, senza per questo provare la stessa sofferenza (“compassione”).
A partire da queste distinzioni, Bloom, a differenza da ciò che apparentemente potrebbe sembrare, non si scaglia in toto contro l’empatia, ma porta dati scientifici e storici a sostegno della scarsa utilità e anzi, della pericolosità in alcuni casi, di una parte specifica dell’empatia, l’empatia affettiva. Per sintetizzare ciò che Bloom esprime anche attraverso un vasto numero di esempi storici più e meno recenti, l’immedesimazione nella sofferenza altrui, se non viene collocata razionalmente in un quadro più ampio, può essere distorta e provocare conseguenze assai negative. Più utile sarebbe invece sperimentare e promuovere la compassione che – dice Bloom – “assumendo il significato di dare valore alle altre persone e prendersi cura del loro benessere ma senza necessariamente sperimentarne la sofferenza, può avere tutti i vantaggi dell’empatia e poche delle sue debolezze”.
Credo che ora andrò a comprare il libro!
Laureata in Psicologia dello Sviluppo presso l’Università di Pavia, è Ricercatrice in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Specializzata presso la Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio-Costruzionista di Milano – Centro Panta Rei, è iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti della Lombardia (n. 16147). È terapeuta EMDR.

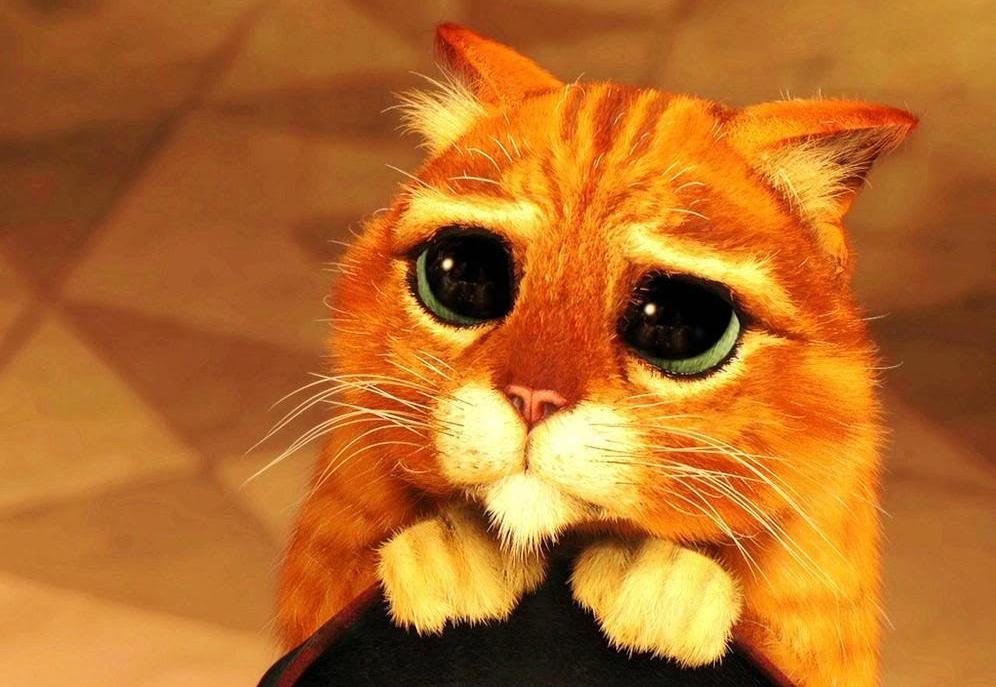
0 comments on “Contro l’empatia?”